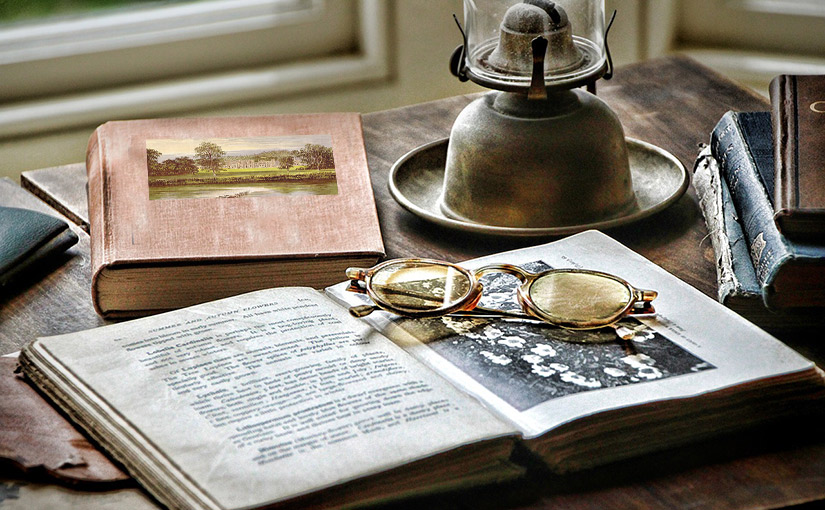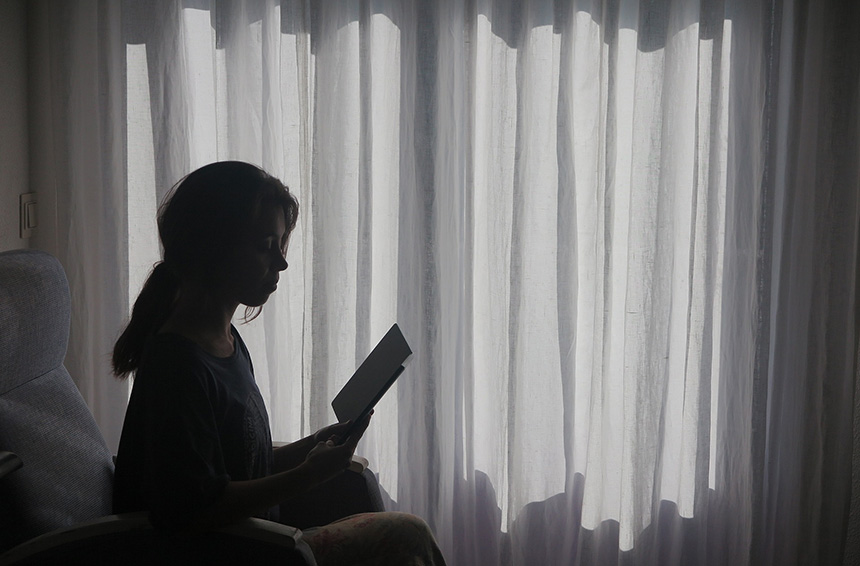Il romanzo storico, genere narrativo che si è diffuso in particolare nel secolo XIX, ha reso la storia un elemento di rilievo della narrazione.
Per romanzo storico si intende un’opera narrativa che si svolge nel passato. Per cui non solo la trama, ma anche gli usi e i costumi, i dialoghi e l’atmosfera generale ricalcano quelli dell’epoca scelta, così da consentire al lettore di calarsi in quel periodo.
È un genere tipicamente romantico e si è diffuso in particolare durante l’Ottocento, grazie a una serie di fattori, come ad esempio: l’affermazione del pensiero e del metodo scientifico che incentivò il rinnovamento degli studi storici; il consolidarsi nell’ambito filosofico dell’idea che le esistenze individuali siano condizionate dalla storia; i crescenti sentimenti nazionalisti che spingevano per un recupero sia delle grandezze passate dei popoli sia di figure esemplari da cui trarre ispirazione.
Un romanzo si può definire storico, quando l’autore del testo non era ancora in vita quando i fatti raccontati sono avvenuti o il libro è stato scritto almeno cinquanta anni dopo quello che è raccontato tra le sue pagine.
Si tratta di un genere in grado di abbracciare vari stili: ucronico (“ucronìa” deriva dal greco e significa “nessun tempo“. Il primo a utilizzare questo termine fu il filosofo francese Charles Renouvier (1815 – 1903) in un saggio, “Uchronie”, del 1857; identifica un genere di narrativa fantastica fondata sulla premessa generale che la storia del mondo abbia seguito un corso alternativo rispetto a quello reale); fanta-storico (il fantasy storico è un sottogenere del fantasy che, per alcuni aspetti, può essere avvicinato al romanzo storico); pseudo-storico (pseudostoria, ambito delle teorie o metodologie che pretendono di essere storiche ma che non rispettano regole e convenzioni del metodo storico. Le teorie pseudostoriche solitamente utilizzano come punto di partenza prove inedite, e/o controverse e/o non accettate dalla comunità scientifica/accademica); multitemporale (particolare versione del romanzo storico in cui si raccontano in parallelo o in successione accadimenti ambientati in epoche storiche diverse, ma collegate tra loro da un elemento: un oggetto, un legame di sangue o qualcosa di metafisico).
Chi si dedica alla scrittura del romanzo storico, un genere che si può definire ibrido, può fare riferimento alle vicende di personaggi realmente esistiti oppure può narrare eventi accaduti a personaggi di pura invenzione.
Le ambientazioni storiche non sono una prerogativa ottocentesca, infatti, già prima del XIX secolo, erano state adottate da William Shakespeare (1564 – 1616) in alcuni sui drammi e persino in Italia, nel Seicento, troviamo esempi simili.
Il XVIII secolo poi, ci ha regalato diversi grandi romanzi realistico sociali, purtroppo, gli autori di quel periodo avevano una certa difficoltà a rendere pienamente le ambientazioni passate. Oltretutto, nei generi che anticipano il romanticismo (in particolare il gotico e il picaresco) la storia non era un elemento essenziale della narrazione, piuttosto un elemento statico, uno scenario su cui proiettare l’azione e le gesta dei personaggi.
Nell’Ottocento, la situazione si ribalta: la storia diventa una vera e propria protagonista della narrazione e gli autori studiano e si documentano affinché i loro scritti risultino attendibili, il più possibile.
Tra i romanzi storici preromantici uno si distingue per aver posto il suo eroe in un quadro storico ben definito, sicuramente frutto di accurati studi su fonti e documenti storici. Si tratta di “Memorie di un cavaliere” (1720) di Daniel Defoe (1660 – 1731). Questo romanzo è una sorta di pietra miliare, in quanto ha dato il via in Inghilterra a un genere letterario nuovo e un secolo dopo, influenzò il lavoro di Walter Scott (1771 – 1832).